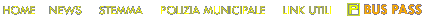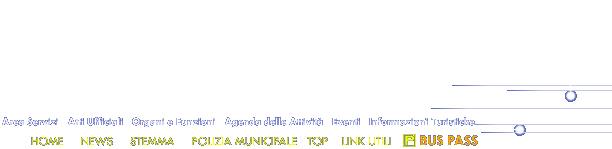|
Le emergenze artistiche ed architettoniche
L’attuale
centro urbano di Amalfi corrisponde totalmente a quello della città
medievale, per cui conserva tuttora imponenti vestigia del passato storico,
individuabili attraverso una lettura stratigrafica nella superfetazione
architettonica delineatasi durante i secoli.
Il monumento per eccellenza che evidenzia tale interessante fenomeno è
senza dubbio il complesso della cattedrale. Esso è formato da due
basiliche accostate e un tempo comunicanti. La più antica era dedicata
alla Vergine Assunta, prima protettrice di Amalfi; fu costruita sui resti
di un’altra cattedrale paleocristiana del VI secolo in forma romanica
ed impostata su tre navate. A questa basilica-cattedrale del IX secolo
ne fu affiancata un’altra nel 987 per interessamento del Duca di
Amalfi Mansone I. Questa nuova cattedrale è anch’essa a tre
navate ed è dedicata all’Apostolo Andrea, protettore dell’intera
diocesi amalfitana almeno sin dalla prima metà del X secolo. La
primitiva cattedrale, poi detta “chiesa del Crocifisso”, fu
trasformata in forma controriformistica e barocca tra il XVI ed il XVII
secolo. Riportata, quindi, alla luce l’antica struttura romanica,
essa ora mostra colonne e capitelli di spoglio, archi acuti, bifore e
monofore duecentesche, affreschi del periodo angioino, tra cui si segnalano
una Madonna con Bambino, i Ss. Cosma e Damiano, il Beato Gerardo Sasso,
fondatore dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, oggi di Malta.
Allo stato attuale la Basilica ospita il Museo di Arte Sacra del Duomo,
tra i cui oggetti esposti assumono particolare rilevanza una mitra angioina
con pietre preziose e ventimila perline autentiche, nonché un calice
smaltato del XIV secolo.
L’elemento artistico di pregervole valore della nuova cattedrale
è senz’altro la porta di bronzo realizzata a Costantinopoli
per volere del ricco mercante amalfitano Pantaleone de Comite Maurone,
il quale la donò all’Episcopio della sua città verso
il 1060. Questa porta presenta quattro figure ageminate in argento, raffiguranti
Cristo, la Vergine, Sant’Andrea e San Pietro. Tale opera rappresenta
il prototipo per una serie di coeve valve bronzee donate dallo stesso
Pantaleone e dalla sua famiglia a San Paolo fuori le mura (Roma), a Montecassino,
a San Michele Arcangelo sul Gargano.
La cattedrale di Sant’Andrea fu trasformata completamente in chiave
barocca agli inizi del XVIII secolo per iniziativa dell’Arcivescovo
Michele Bologna; testimonianze di questo intervento sono le tele del pittore
napoletano Andrea d’Aste, rievocanti il martirio di Sant’Andrea,
e il soffitto in oro zecchino.
Il transetto della cattedrale, che mostra tuttora archi intrecciati di
stile moresco, fu realizzato nei primi anni del Duecento per volere dell’arcivescovo
Matteo di Capua, insieme alla sottostante cripta. In questa, l’8
maggio 1208, il Cardinale amalfitano Pietro Capuano, legato pontificio
alla IV crociata, introdusse le spoglie dell’Apostolo Andrea, che
trasportò via mare da Costantinopoli; un affresco del 1610 di Aniello
Falcone rievoca l’avvenimento, mostrando le strutture architettoniche
della primitiva cattedrale romanica.
Sulla tomba dell’Apostolo fu realizzato, nei primi anni del Seicento,
un altare che presenta la statua bronzea di Sant’Andrea, opera di
Michelangelo Naccherino, e quelle marmoree dedicate da Pietro Bernini
ai Martiri Lorenzo e Stefano.
In quegli stessi anni furono affrescate le volte a crociera della cripta,
mediante scene della vita di Cristo. Sin dal 1304 sulla tomba dell’Apostolo
si verifica un “segno particolare”, cioè la comparsa
in quantità variabili di un liquido oleoso, incolore, inodore ed
insapore denominato “manna”. Secondo la tradizione questa
manna avrebbe compiuto numerosi miracoli, guarendo fedeli locali e pellegrini.
Dalla parte settentrionale della primitiva cattedrale l’Arcivescovo
Filippo Augustariccio edificò, nel 1268, il Chiostro Paradiso,
un cimitero per nobili, identificato da un quadriportico con archi intrecciati
poggianti su colonnine binate, nel quale sono evidenti sei cappelle affrescate;
l’opera pittorica di maggior rilievo è, a tal proposito,
la Crocifissione attribuita alla scuola napoletana di Giotto.
Di fronte al Chiostro si erge il campanile della cattedrale, che fu realizzato
in stile romanico tra il 1180 e il 1276; in quest’ultima data fu
costruita la cella campanaria in stile moresco per volere dell’Arcivescovo
Filippo Augustariccio.
Il centro urbano di Amalfi può essere considertato a giusta ragione
una sorta di museo vivente, poiché conserva, alquanto intatte,
le testimonianze architettoniche ed urbanistiche del suo passato, rileggibili
attraverso la stratificazione dei secoli. Tra queste emergenze architettoniche
si segnalano chiese e cappelle, monasteri e conventi (alcuni dei quali
diventati alberghi già nel XIX secolo), dimore dell’aristocrazia
mercantile medievale, torri e mura.
Nella parte più interna, oggi detta “Valle dei Mulini”,
sono tuttora presenti le imponenti vestigia delle antiche cartiere amalfitane
che, sin dal XIII secolo, producevano la celebre “carta a mano”,
mediante processi tecnologici appresi dal mondo arabo e migliorati in
loco. Allo stato attuale la maggior parte di tale edifici si trova nella
condizione di rudere; solo due cartiere sono tuttora attive, mentre è
in funzione il Museo della Carta, che offre ai visitatori un’esaustiva
rivisitazione storica di tale antica attività protoindustriale.
L’ultima costruzione individualbile nell’interno della Valle
è la Ferriera di Amalfi, un opificio per l’estrazione del
ferro dai minerali grezzi e per la produzione dell’acciaio, risalente
al XIV secolo che è, pertanto, tra i più antichi dell’Italia
meridionale.
Testi
a cura del Prof. Giuseppe Gargano
|